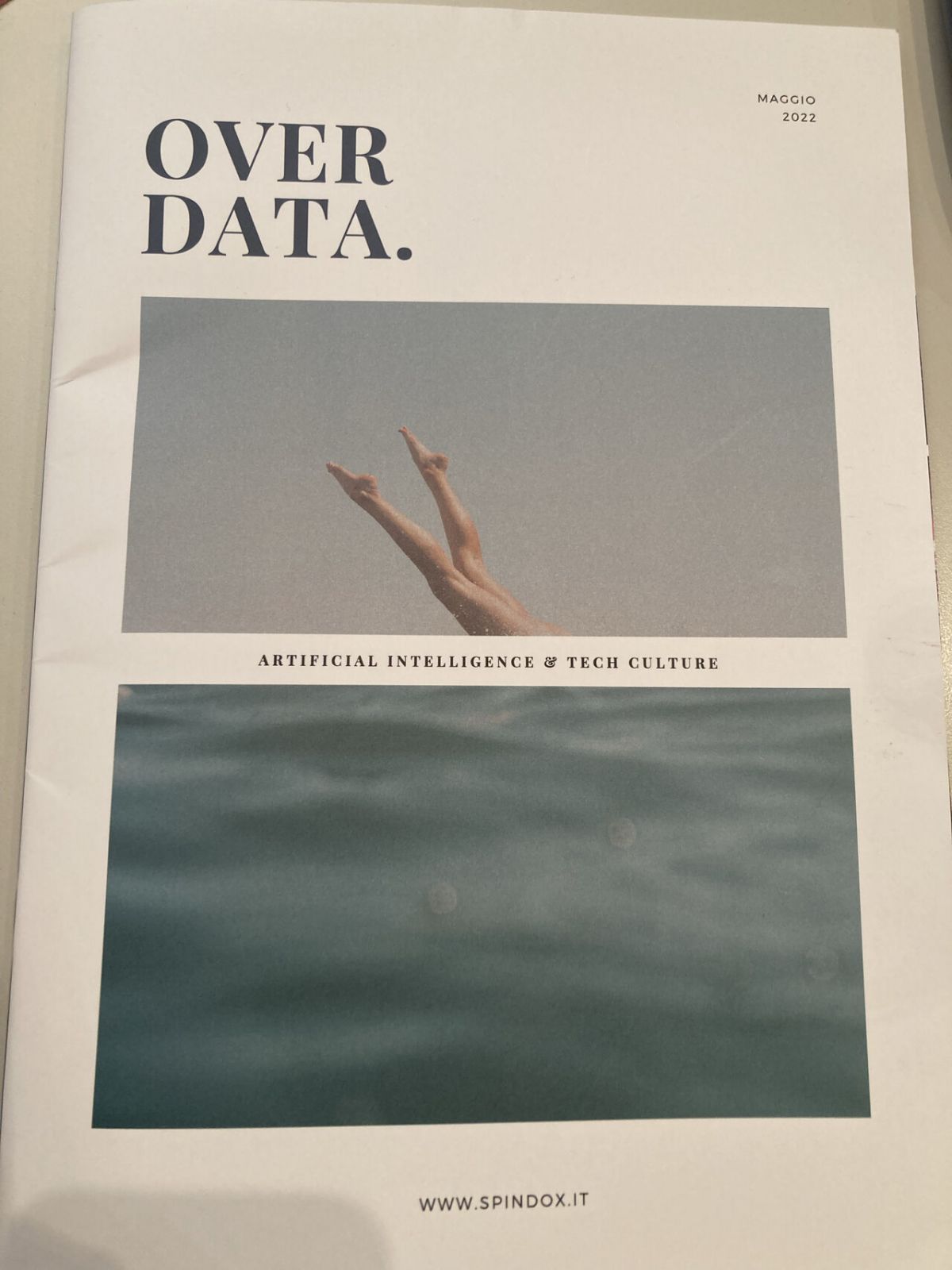Tradurre o tradire il GDPR?
Tra gli obiettivi primari del GDPR (“General data protection Regulation”) vi è quello di uniformare e armonizzare le normative interne agli Stati membri in tema di privacy, favorendo l’applicazione del principio di libera circolazione e di sviluppo del mercato digitale UE – a cui oggi viene riconosciuto un valore potenziale stimato di 415 miliardi di euro annui.
Per fare ciò, il Legislatore europeo ha attribuito un forte rilievo alle parole e al loro significato, al fine di condurre i destinatari della normativa verso la corretta applicazione del Regolamento, fornendo alcuni spunti interpretativi nei Considerando – ben 173 – che compongono il corpus normativo.
Da qui nasce l’esigenza di una corretta traduzione del GDPR, affinché i principi del dettame possano raggiungere i destinatari del precetto senza alcuna interferenza linguistica.
Per questa ragione, la polemica che negli ultimi mesi ha alimentato le discussioni sulla versione italiana del testo del GDPR, appare molto di più di una mera questione di glottologia.
Un primo esempio lampante di tale disallineamento viene offerto dal termine “audit” (definito nella norma UNI EN ISO 19011:2012 quale processo sistematico, indipendente e documentato che implica un necessario percorso formale di valutazione e soddisfacimento degli obiettivi prefissati) citato in 4 articoli del GDPR (28, 39, 47 e 58), e tradotto in italiano con – ben – tre diversi termini di natura generica: revisione, controllo e verifica.
E ancora, i dubbi inerenti alla possibilità di configurare un Responsabile del trattamento Interno non sono altro che la logica conseguenza di una traduzione asettica e poco raffinata (“Responsabile”) del termine anglofono “processor” il cui intimo significato indica necessariamente un soggetto esterno (e mai interno!), a differenza di quanto avviene per il termine responsabile, che per sua natura può essere esterno ed interno.
Inoltre, se il Considerando n.4 del testo originario in lingua inglese del GDPR recita testualmente: “The right to the protection of personal data is not an absolute right”, la versione italiana ha previsto una traduzione “grossolana” del termine “right” il cui significato è stato “trasformato” da “diritto” in “prerogativa” (concetto quest’ultimo – ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi – che nel nostro ordinamento assume una valenza del tutto differente).
Quelle citate, è bene precisarlo, sono solo alcune delle “sviste” e dei – forse – evitabili disallineamenti linguistici che agli occhi dei più potrebbero risultare grattacapi di poco conto.
Tuttavia, come fatto dal Legislatore europeo, è bene porre la giusta attenzione sul tema affinché gli scopi della normativa non vengano disattesi.
In altre parole, ben venga la traduzione del GDPR purché non se ne tradisca irrimediabilmente lo spirito ed il senso.